Radici per terra e testa verso il cielo. Lo scrive Erri De Luca. Lo pensi guardando le fotografie di Stefano Schirato. Un incontro ravvicinato con la sua storia di fotoreporter è stata un’occasione preziosa per conoscere meglio il suo modo di vivere e intendere la fotografia. Stefano era uno degli incontri nell’ambito di Loreto View, un Festival che fra mostre, eventi enogastronomici, incontri, ha fatto passare , sentire e gustare vari tipi di bellezza in arrivo dall’Abruzzo e dal mondo fuori dell’Abruzzo.
L’occasione era la presentazione del “fotoreportage” One Way, un multimedia realizzato in Grecia per raccontare le ondate di migranti in viaggio dal medio oriente verso altri mondi.
Ma prima è stato possibile vagabondare dentro la sua storia, dentro le sue idee, dentro le foto di cui il corrispondente del New York Times “nato-a-Bologna-ma-cresciuto-e-stabilito-a-Pescara” ha svelato ispirazioni e retroscena davanti ad un pubblico tanto attento da ascoltare rapito e in silenzio le sue gesta.
 Gli inizi: “Avevo 25 anni, sentivo il richiamo verso la fotografia e leggendo su un giornale di ciò che avveniva in Cambogia sono partito – racconta – Rimasi colpito dai bambini che giocavano su cumuli di rifiuti, ci sprofondavano dentro. Ne è nato un reportage, è stato il primo.Di fronte a questo primo
Gli inizi: “Avevo 25 anni, sentivo il richiamo verso la fotografia e leggendo su un giornale di ciò che avveniva in Cambogia sono partito – racconta – Rimasi colpito dai bambini che giocavano su cumuli di rifiuti, ci sprofondavano dentro. Ne è nato un reportage, è stato il primo.Di fronte a questo primo  passo non sapevo come continuare. Poi le storie sono arrivate una dopo l’altra: io le ho cercate, altre ho avuto la possibilità trovarmele sul cammino perché i giornali mi chiamavano perché le raccontassi. Poi, ho avuto anche la fortuna di sceglierle”.
passo non sapevo come continuare. Poi le storie sono arrivate una dopo l’altra: io le ho cercate, altre ho avuto la possibilità trovarmele sul cammino perché i giornali mi chiamavano perché le raccontassi. Poi, ho avuto anche la fortuna di sceglierle”.
Quanto tempo è passato dalla foto dei due gorilla abbracciati scattata in Sud Africa, alla prima pericolosa incursione, sempre lì, nel quartiere nero: “Ho imparato che per fare certe cose bisogna avere delle guide del posto – ha detto – Io e la persona che mi accompagnava ce la potevamo vedere bruttissima se non fossimo riusciti a scappare in tempo. Ma è servito a capire cosa dovevo raccontare”.
 I suoi lavori sono tanti, cataloghi, libri, mostre,decine di reportage per il New York Times che appena visto i suoi lavori gli ha inviato il contratto di collaborazione per mail, tante riviste italiane, biglietto da visita per altri mondi catturati dalla sua curiosità, esplorati attraverso un obiettivo silenzioso, capace di aspettare per dare voce a quelle che Schirato chiama “Persone senza volto”. “Sono i malati di cancro di Taranto incontrati all’Ilva, che per continuare a lavorare non confessavano la malattia. Sono i pentiti di mafia che dovevo ritrarre celando, come potevo, sembianti che non potevano essere svelati. Sono le persone come l’uomo incontrato a Cernobyl, uno dei nonni di bambini deformi che non era più tornato a casa dopo la tragedia e che io ho riaccompagnato sulla strada della sua vecchia vita, catturando il suo sguardo pieno di tutto quello che poteva significare uscire, o meglio, stare dentro una storia come quella. Una storia universale, valida per tutti, capace di sintetizzare i sentimenti di tutti coloro che hanno vissuto quella tragedia. Ci sono storie che non riesco a togliermi di dosso. Questa è una di quelle”.
I suoi lavori sono tanti, cataloghi, libri, mostre,decine di reportage per il New York Times che appena visto i suoi lavori gli ha inviato il contratto di collaborazione per mail, tante riviste italiane, biglietto da visita per altri mondi catturati dalla sua curiosità, esplorati attraverso un obiettivo silenzioso, capace di aspettare per dare voce a quelle che Schirato chiama “Persone senza volto”. “Sono i malati di cancro di Taranto incontrati all’Ilva, che per continuare a lavorare non confessavano la malattia. Sono i pentiti di mafia che dovevo ritrarre celando, come potevo, sembianti che non potevano essere svelati. Sono le persone come l’uomo incontrato a Cernobyl, uno dei nonni di bambini deformi che non era più tornato a casa dopo la tragedia e che io ho riaccompagnato sulla strada della sua vecchia vita, catturando il suo sguardo pieno di tutto quello che poteva significare uscire, o meglio, stare dentro una storia come quella. Una storia universale, valida per tutti, capace di sintetizzare i sentimenti di tutti coloro che hanno vissuto quella tragedia. Ci sono storie che non riesco a togliermi di dosso. Questa è una di quelle”.
 Oppure della mamma di Sarajevo, colpita dal cecchino davanti agli occhi di sua figlia di quattro anni, oggi ventenne, diventata pazza per aver vissuto impotente quella scena. Oppure le mamme di Castiglion delle Stiviere, le madri assassine, folli creature raccontate per Vanity Fair: “Sono entrato in quel carcere sapendo che non sarei uscito
Oppure della mamma di Sarajevo, colpita dal cecchino davanti agli occhi di sua figlia di quattro anni, oggi ventenne, diventata pazza per aver vissuto impotente quella scena. Oppure le mamme di Castiglion delle Stiviere, le madri assassine, folli creature raccontate per Vanity Fair: “Sono entrato in quel carcere sapendo che non sarei uscito  allo stesso modo – racconta – sono stato accolto da una donna che correva verso di me prendendosi i seni in mano e la bava alla bocca, in preda ad un delirio che solo chi ha toccato quella follia può provare. Ho sentito il loro baratro e l’ho raccontato, ma non per giustificarlo, bensì perché c’è in ognuno di noi, ma in chi è folle esplode nel gesto più estremo che un essere umano possa compiere”.
allo stesso modo – racconta – sono stato accolto da una donna che correva verso di me prendendosi i seni in mano e la bava alla bocca, in preda ad un delirio che solo chi ha toccato quella follia può provare. Ho sentito il loro baratro e l’ho raccontato, ma non per giustificarlo, bensì perché c’è in ognuno di noi, ma in chi è folle esplode nel gesto più estremo che un essere umano possa compiere”.
 Bellissimo il racconto degli equipaggi dimenticati, un’avventura giovanile, fatta grazie a due cappellani emiliani che lo hanno “traghettato” su bastimenti fermi in porto dimenticati dalla burocrazia e dal mondo di casa, impaludati in una tristezza di riviste, donnine e noia e speranza di tornare da dove sono venuti. Come lo è il punto di vista sulle persone affette da nanismo, trovato durante una delle
Bellissimo il racconto degli equipaggi dimenticati, un’avventura giovanile, fatta grazie a due cappellani emiliani che lo hanno “traghettato” su bastimenti fermi in porto dimenticati dalla burocrazia e dal mondo di casa, impaludati in una tristezza di riviste, donnine e noia e speranza di tornare da dove sono venuti. Come lo è il punto di vista sulle persone affette da nanismo, trovato durante una delle  scene del film di Tornatore La migliore Offerta: “Ho chiesto loro cosa li colpisse di più della vita “normale”, cose tipo il non poter suonare i citofoni o non arrivare a cose poste in alto. Mi hanno risposto tutti che il dolore provato per via dello sguardo della gente non aveva uguali. E allora mentre li ho fotografati in ginocchio per provare a capire. Mi è bastato lo sguardo di un cane incuriosito da quell’uomo alla sua altezza a raccontare esattamente la loro emozione precisa”.
scene del film di Tornatore La migliore Offerta: “Ho chiesto loro cosa li colpisse di più della vita “normale”, cose tipo il non poter suonare i citofoni o non arrivare a cose poste in alto. Mi hanno risposto tutti che il dolore provato per via dello sguardo della gente non aveva uguali. E allora mentre li ho fotografati in ginocchio per provare a capire. Mi è bastato lo sguardo di un cane incuriosito da quell’uomo alla sua altezza a raccontare esattamente la loro emozione precisa”.
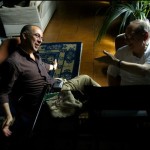 Tornatore, Morricone, il cast dell’ultimo film, la foto modello Quarto Stato dal set di Baaria, l’ultima strepitosa immagine di Geoffrey Rush nell’ultima strepitosa scena del thriller del regista siciliano, di cui lui non è il foto-biografo, ma una parentesi bella fra foto e immagini: “Due aneddoti, una foto di lui con Morricone mentre gli fa suonare a tradimento la colonna sonora del suo film che il maestro non voleva suonare, io ho scattato quando, beffato,
Tornatore, Morricone, il cast dell’ultimo film, la foto modello Quarto Stato dal set di Baaria, l’ultima strepitosa immagine di Geoffrey Rush nell’ultima strepitosa scena del thriller del regista siciliano, di cui lui non è il foto-biografo, ma una parentesi bella fra foto e immagini: “Due aneddoti, una foto di lui con Morricone mentre gli fa suonare a tradimento la colonna sonora del suo film che il maestro non voleva suonare, io ho scattato quando, beffato,  Morricone lo manda a quel paese – racconta – Baaria: avevo 3 minuti per il mio scatto, non gli dissi che volevo riprodurre il quadro da cui sono felicemente perseguitato da quando ero ragazzo. Ero su una sedia ho detto a lui fra i figuranti di camminare verso di me e la foto che cercavo è arrivata. Il mio Quarto stato! Rush aveva un’ultima scena da brivido, immerso nel fumo, in pochissima luce, aspettavo lo stop di Tornatore per scattare subito dopo, ma il led rosso della messa a fuoco della macchinetta si è stampato sulla fronte di lui un millesimo di secondo prima che desse lo stop fini. E così mi ha mandato a quel paese. Ma il giorno dopo era lì che mi faceva i complimenti per la foto”.
Morricone lo manda a quel paese – racconta – Baaria: avevo 3 minuti per il mio scatto, non gli dissi che volevo riprodurre il quadro da cui sono felicemente perseguitato da quando ero ragazzo. Ero su una sedia ho detto a lui fra i figuranti di camminare verso di me e la foto che cercavo è arrivata. Il mio Quarto stato! Rush aveva un’ultima scena da brivido, immerso nel fumo, in pochissima luce, aspettavo lo stop di Tornatore per scattare subito dopo, ma il led rosso della messa a fuoco della macchinetta si è stampato sulla fronte di lui un millesimo di secondo prima che desse lo stop fini. E così mi ha mandato a quel paese. Ma il giorno dopo era lì che mi faceva i complimenti per la foto”.
Passione, anche formazione con la sua “scuola”, Mood, carta con Simone Cerio e Marco Di Vincenzo, un modo per aprire finestre per chi ama la fotografia, non per insegnare, ma per offrire esperienza ricevendo socialità in cambio e l’occasione di scoprire l’Abruzzo attraverso tradizioni, riti, personaggi che non aveva ancora esplorato. “Non posso insegnare nulla a nessuno, non è questa la prospettiva. In Italia la situazione è quella che è, al mondo ci sono tantissimi fotografi bravi, di valore, ma poche opportunità di avanzare, di allargare i confini di  questo mondo, perché i giornali che fanno la differenza sono una 40ina in tutto. E’ cambiato il modo di rapportarsi alla fotografia. Io posso dire di amare quella che non descrive, ma dà voce. Non sono un giornalista, ma mi catturano le storie e sono quelle che cerco di fissare quando scatto”.
questo mondo, perché i giornali che fanno la differenza sono una 40ina in tutto. E’ cambiato il modo di rapportarsi alla fotografia. Io posso dire di amare quella che non descrive, ma dà voce. Non sono un giornalista, ma mi catturano le storie e sono quelle che cerco di fissare quando scatto”.
Lo ha fatto nella sua prima foto d’autore, a Pienza, su una via dell’amore immortalato nell’incontro inatteso di un vecchietto e una signora. O in quella, sempre a Sarajevo della bimba con l’abito rosa che giocava ogni giorno fra le tombe del padre e dello zio che non ha mai conosciuto.
Lo ha fatto in sud Marocco, per raccontare l’identità negata agli Saharawi, un popolo nel popolo che il regno non vede, costata a Stefano e alla giornalista Genny Pacini due giorni di paura, perché sono stati  trattenuti e che diverrà presto una mostra e un documentario.
trattenuti e che diverrà presto una mostra e un documentario.
Lo farà ancora in Puglia e a Lampedusa, per raccontare, come fa in One Way, l’universo dei migranti che raccolgono pomodori per vivere.
Lo farà attraverso gli occhi di un fotografo un po’ nomade che torna a riprendere forze nell’abbraccio della sua donna e dei suoi tre bambini, prima di partire ancora.









